Care lettrici e cari lettori di Intercultura blog, avete mai sentito parlare delle oggettive oblique o oggettive improprie? Vediamo insieme di cosa si tratta.
Buona lettura!
Prof. Anna
Le proposizioni oggettive hanno funzione di oggetto diretto della principale, rispondono alla domanda che cosa?, chi? e dipendono da un verbo transitivo: capisco (che cosa?) che sei stanco.
Ci sono proposizioni che fungono da oggetto del predicato della reggente pur rispondendo alle domande di che cosa?, a che cosa (e non che cosa?). Queste proposizioni sono chiamate oggettive oblique e sono introdotte da verbi o espressioni che, pur non essendo transitivi, sono di questi equivalenti (sono transitivi dal punto di vista logico):
→ prometto (che cosa?) che verrò (oggettiva vera e propria);
→ sono convinto (di che cosa?) che verrai (oggettiva obliqua).
Le oggettive oblique possono dipendere:
• da verbi intransitivi pronominali: accorgersi, illudersi, accontentarsi, assicurarsi, convincersi, congratularsi, degnarsi, persuadersi, rallegrarsi, rammaricarsi, scusarsi, sforzarsi, vergognarsi, lamentarsi, ricordarsi ecc.: mi sono ricordato (di che cosa?) di telefonarti (oggettiva obliqua);
• da alcuni verbi non pronominali: dubitare, pensare ecc.: dubito di poter venire;
• da alcune espressioni: essere a conoscenza, rendersi conto, essere sicuro (certo, convinto, in dubbio), fare finta, avere paura, avere la certezza (la convinzione, la speranza, il dubbio), avere vergogna, fare attenzione ecc.: ha fatto attenzione a non offendere nessuno.
Le oggettive oblique esplicite sono introdotte dagli elementi tipici delle oggettive vere e proprie: che, come, quanto, se, del fatto che: mi rendo conto (di che cosa?) che (del fatto che) ho sbagliato; sono consapevole (di che cosa?) del fatto che dovrò impegnarmi molto.
Le oggettive oblique implicite possono essere introdotte da di + infinito: mi scuso di essere stato scortese o da a + infinito: ha sofferto a vedere quello spettacolo.
Lo o ne?
Le oggettive vere e proprie possono essere richiamate dal pronome diretto lo, che le sostituisce: “capisco che è stanco” “Lo capisco anch’io” (capisco qualcosa).
Le oggettive oblique sono spesso richiamate dalla particella ne: “mi sono accorto che ho sbagliato” “Me ne sono accorto anch’io” (mi accorgo di qualcosa).
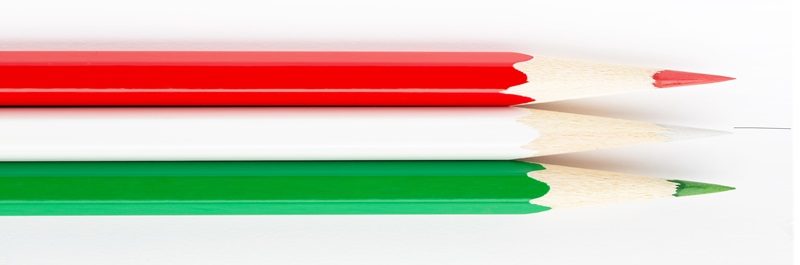
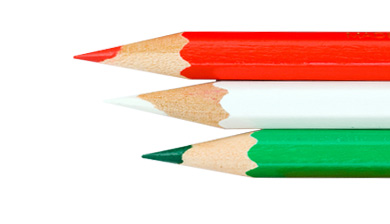
Grazie.
Mi sembra un bel argomento ma un po’ difficile.Posso capire, comprendere la differenza dei due tipi di frasi e le regole grammaticali per ognuno(per ogni tipo), pero’ a dire la verita’:se io dovessi formulare le due prime frasi dell’esempio, non potrei farlo,nonostante che io possa capire la differenza tra esse.
Si puo’ dire che “la oggettiva obliqua” e’ un po’ come qualcosa di ipotetico?che non e’ qualcosa di una certezza?-
Sarei grata per il tuo chiarimento
kdela
Cara Kdela, l’oggettiva obliqua non è ipotetica, è una frase retta da verbi che, per loro natura, invece di reggere la domanda “che cosa?”, reggono la domanda “di che cosa” per introdurre un complemento oggetto, ad esempio l’espressione “sono convinto” regge “di che cosa?”: “sono convinto di poter venire”, e quindi, quando andrò a sostituire l’oggettiva obliqua, dovrò usare “ne”: “ne sono convinto” (=sono convinto di questo, di poter fare questo).
Spero di aver chiarito il tuo dubbio.
A presto
Prof. Anna
Benissimo.
Grazie Mille
Cara Prof. Anna,
mai sentito, lezione molto interessante.
possiamo dire che quella è la ciliegia sulle prime lezioni relative alla proposizione oggettiva?
Piano piano ci avviciniamo all’analisa logica. delle frasi. Sarà una sfida!
Grazie
Una correzione: “un bell’argomento”.
Scusa
10/10, ma non…
Cara Anna:
Non capisco perchè la numero otto richiama il ne. Quando traduco la frase al inglese, penso che usero lo dubito. Per carita mi puo spiegare?
Cara Maria, la costruzione è: “dubitare di qualcosa” e non “dubitare qualcosa”, quindi è necessario usare “ne”.
A presto
Prof. Anna
E’ stato un bel esercizio. Tante grazie Prof. Anna. María Cristina Bardi
Quanto brava che sei professoressa Anna! Ti amo!!!
“Giulio non poteva sapere che quella roba fosse nella macchina (contemporaneità nel passato, con il congiuntivo nella subordinata in quanto “non poteva sapere” nella principale ammette il congiuntivo appunto nella subordinata)”;
“Il presentatore non poteva sapere che la ragazza del pubblico stesse sulla sedia a rotelle (contemporaneità nel passato, stesso ragionamento per la prima frase)”;
“I ragazzi non sanno che non devono vandalizzare la città (contemporaneità nel presente)”;
In primis le volevo chiedere se le concordanze siano esatte? e poi ho un dubbio: nell’ultima frase, dopo il “che”, non dovrebbe esserci il congiuntivo? nel senso che la principale è retta da “non sapere”, quindi penso ci voglia il congiuntivo nella subordinata… può essere forse che viene utilizzato l’indicativo in quanto il “che” introduce una proposizione oggettiva (la quale è una proposizione argomentale, cioè che espande uno degli argomenti della frase principale) che indica un fatto reale ed obiettivo (cioè che la città non va assolutamente vandalizzata)? e che quindi l’uso dell’indicativo e del congiuntivo non rispecchia solo una contrapposizione tra oggettività e soggettività, tipica di questi modi verbali?
Cara Chiara, le concordanze sono corrette. Dopo il verbo “sapere” preceduto da negazione si può usare anche l’indicativo, in particolar modo in una modalità medio-informale della lingua.
Un saluto
Ok, ma se invece volessi adottare una modalità medio-formale (o comunque formale), potrei dire anche, rispetto a quello che dice, “I ragazzi non sanno che non debbano vandalizzare la città (contemporaneità nel presente)”?
Cara Chiara, in questo caso io userei comunque l’indicativo.
1)”Immagino che tuo marito non sappia che tu lo tradisca (ma anche “tradisci”)”
…”Immagino”, principale; “che tuo marito non sappia”, subordinata oggettiva di primo grado al congiuntivo perché nella principale (e anche reggente) c’è il verbo “immaginare” (“immagino”) che solitamente ammette il congiuntivo in una subordinata (“non sappia”); “che tu lo tradisca (ma anche “tradisci”)”, subordinata oggettiva di secondo grado al congiuntivo, perché retta dalla reggente (la subordinata di primo grado) in cui è presente il verbo “sapere” preceduto da negazione (“non sapere”=”non sappia”) che può reggere, oltre al congiuntivo “tradisca”, anche l’indicativo in particolar modo in una modalità medio-informale della lingua. Quindi nella subordinata oggettiva di secondo grado usiamo il congiuntivo “tradisca”, in questo caso, perché (come si legge sulla Treccani) i verbi che usano regolarmente l’indicativo (come “sapere”) possono tuttavia ricorrere al congiuntivo se la reggente è di significato negativo (“non sapere” = “non sappia”); ma potremmo usare anche l’indicativo se ci trovassimo in una modalità medio-informale della lingua, e comunque potremmo usare l’indicativo perché il fatto della subordinata oggettiva di secondo grado è presentato come reale (e cioè “è vero che il marito è all’oscuro del tradimento della moglie, ma il fatto è comunque avvenuto e continua ad accadere”)
2)”Immagino che tuo marito sappia che tu lo tradisci”
…”Immagino”, principale; “che tuo marito sappia”, subordinata oggettiva di primo grado; “che tu lo tradisci”, subordinata oggettiva di secondo grado in cui però usiamo soltanto l’indicativo (“tradisci”) perché il verbo “sapere” (“sappia”) della reggente di primo grado è di significato positivo (quindi “sapere”- “sappia”- in forma affermativa regge l’indicativo in una subordinata) e poi perché anche qui il fatto viene presentato come reale.
3)”Ovviamente tuo marito non sa che tu lo tradisci/ tradisca”
…Stesso discorso come per la prima frase per quanto riguarda il modo (indicativo/congiuntivo), ma c’è una subordinata in meno: infatti “Ovviamente tuo marito non sa”, principale; “che tu lo tradisca (ma anche “tradisci” per il discorso soprascritto)”, subordinata oggettiva di primo grado.
In finale, relativamente alla prima e alla terza frase il congiuntivo, come l’indicativo, sono entrambi corretti: il congiuntivo in un contesto formale e perché “sapere” è di significato negativo mediante la negazione; l’indicativo in un contesto medio- informale o perché il fatto viene presentato come reale.
Penso sia tutto corretto
Cara Chiara, è corretto.
“Non sapevo che fosse vegetariana”: la principale è “non sapevo”; “che fosse vegetariana” è una subordinata oggettiva al congiuntivo, perché “non sapere” nella principale regge il congiuntivo nella subordinata (la subordinata esprime contemporaneità al passato rispetto alla principale).
Giusto?
Caro Paolo, è corretto.
“Penso che qualcosa sia andato storto”; il “che” introduce una subordinata oggettiva al congiuntivo, retto da “penso”.
Un saluto
Esatto.
“Aspetta che mi crescano i capelli, poi ne riparliamo!”. “che mi crescano i capelli” è una subordinata oggettiva retta dal verbo della principale “Aspetta”, che vuole il congiuntivo nella subordinata.
Corretto?
Caro Gregorio, esatto.
“accorgersi che” in forma affermativa vuole l indicativo; in forma negativa congiuntivo: mi sono accorto che era deforme; non mi sono accorto che fosse deforme.
Caro Emilio, è corretto, ma è possibile trovare anche l’indicativo.
Perfetto quindi in “accorgersi” in forma negativa sono corretti sia il congiuntivo sia l’indicativo: “Non si era accorta che il microfono fosse aperto (ma anche “era aperto”)”.
Esatto?
Esatto.
Subordinata oggettiva congiuntivo e indicativo:
1Ho detto che era intelligente (verbo del dire, indicativo nella subordinata)
2Non ho detto che fosse intelligente (dire in forma negativa regge il congiuntivo e dà piu incertezza alla subordinata; ma non scarterei comunque l indicativo, che darebbe alla subordinata stessa più certezza)
Cara Isa, corretto.
CONDIZIONALE NELL’OGGETTIVA:
…Un’oggettiva può essere costruita anche con il condizionale, che dà all oggettiva, insieme ad un ipotesi sottointesa, una sfumatura di eventualità (quindi con la possibilità che avvenga o non avvenga qualcosa) nell’apodosi di un periodo ipotetico (anche con l ipotesi, o protasi, sottointesa):
“Ho paura che loro potrebbero non adattarsi alla realtà (se, qualora dovessero nascere, ecc; quindi “loro non sono ancora nati” e non è detto che nascano)”.
…Invece se usassi, per esprimere posteriorità, il futuro semplice, daremmo, dal mio punto di vista, all’oggettiva sempre una sfumatura di incertezza, rispetto al futuro, ma di certezza relativamente al fatto che “loro sono nati”: e cioè “loro esistono e rischieranno (ma non è certo) di non adattarsi alla realtà, rispetto invece alla protasi del primo periodo, che ipotizza la loro nascita (quindi non sono ancora nati):
“Ho paura (adesso) che (in futuro) loro non si adatteranno alla realtà”. In questa frase il futuro semplice nella subordinata implica, rispetto al condizionale e alla protasi del primo periodo, che effettivamente “loro sono nati” (c’è qualcuno che è nato), ma che rischieranno (quindi non è detto) di non adattarsi alla realtà.
È un ragionamento un po’ complesso, ma credo che sia corretto.
Caro Michele, il ragionamento è corretto, ma questo non significa che se io dico “Ho paura che loro potrebbero non adattarsi alla realtà” io stia parlando di esseri non nati, potrebbero anche essere già nati, si tratta di sfumature di significato, in questo caso il condizionale dà una sfumatura eventuale, ma è necessario, per capire il senso della frase, considerare bene il contesto.
Sono d’accordo, infatti nel mio esempio è sottointeso “se dovessero nascere, ho paura che…”; quindi è un’ipotesi: non è nato ancora qualcuno (e magari non nascerà mai, non si sa). Ma “se dovessero nascere, potrebbero non adattarsi alla realtà”.
L’oggettiva è sempre retta da una principale? Nel periodo “quando si accorsero di essere finiti in aperta campagna, ebbero la sensazione di di aver sbagliato la strada”, “di essere finiti in aperta campagna” non è un’oggettiva? Ma “quando si accorsero” non è forse una temporale?
Grazie!
Cara Valeria, un’oggettiva ha sempre una frase che la regge (reggente), che però non è necessariamente la principale. Nel periodo che mi scrivi, ad esempio, la principale è: “ebbero la sensazione”, “quando si accorsero” è subordinata temporale di primo grado (cioè subordinata alla principale) temporale, “di essere finiti” è una subordinata di secondo grado (cioè subordinata a una subordinata) oggettiva.
Un saluto
Le proposizioni oggettive esplicite sono introdotte da che e possono avere il verbo anche al condizionale. Infatti, un’oggettiva può essere costruita anche con il condizionale nell’apodosi di un periodo ipotetico (anche con la protasi sottointesa). Perciò potremmo scrivere: “Non penso che sarebbe stato noioso” (sottointeso “se ci avessimo provato”; quindi un periodo ipotetico dell’irrealtà) e “Non penso che sarebbe noioso” (sottointeso “se ci provassimo”; quindi un periodo ipotetico della possibilità). Ah, le stesse frasi potremmo scriverle nel seguente modo, ma con l’apodosi in un inciso, e quindi racchiusa tra due virgole: “Non penso che, se ci provassimo, sarebbe noioso” e “Non penso che, se ci avessimo provato, sarebbe stato noioso”.
Mi sembra tutto corretto…
Caro Giulio, è tutto corretto.
Buonasera,vorrei gentilmente chiedere se nel periodo
“BUONASERA,vorrei sapere se nel periodo “AMMIRO CHI STUDIA”
vi sia una subordinata oggettiva che può essere facilmente scambiata x una relativa,nel qual caso il verbo ammiro nn avrebbe una subordinata oggettiva,con la conseguenza che il verbo della principale AMMIRO, risulterebbe privo di autonomia e di significato.Se sbaglio mi corregga.
Grazie mille
Cara Annamaria, la proposizione introdotta da “chi” (che è un pronome relativo) è una relativa, non un’oggettiva.
Un saluto e a presto
Gentile prof.Anna
come si distingue la subordinata oggettiva obliqua implicita e subordinata dichiarativa implicita?
“gli hanno dato un’opportunità di scappare.”
“il sospetto ha convinto la polizia di essere innocente.”(a volte subordinata obliqua contiene anche un oggetto?)
nella prima frase, posso cambiare la preposizione (di—da scappare) così, diventa subordinata relativa implicita?
grazie mille
Caro Luca, le oggettive oblique sono comunque espansioni di un verbo: sono introdotte da verbi o espressioni che, pur non essendo transitivi, sono di questi equivalenti, verbi che per loro natura reggono un complemento introdotto da una preposizione, ma che dal punto di vista logico è un complemento oggetto (il sospetto ha convinto la polizia di essere innocente: sospettare di qualcosa); mentre le proposizioni dichiarative sono espansione di un elemento nominale della reggete: gli hanno dato l’opportunità di scappare (“di scappare” è un’espansione dell’elemento nominale “opportunità”). Nella prima frase non è possibile sostituire “di” con “da”.
Un saluto